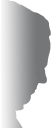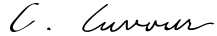Incontri Cavouriani
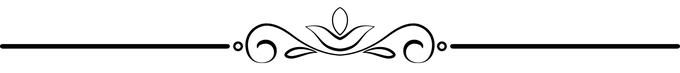
Archivio
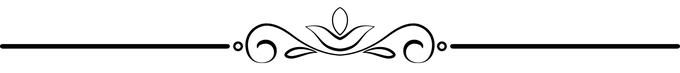

Umanismo e Giustizia nel Risorgimento
“Umanismo e Giustizia nel Risorgimento” *
di Alessandro Provera
tratto da “Giustizia e Letteratura II”, a cura di Gabrio Forti, Claudia Mazzuccato, Arianna Visconti
* Il presente saggio trae origine dalla relazione tenuta in occasione del seminario dal titolo Contro e in nome dell’Imperatore. Due volti del Risorgimento in letteratura, nell’ambito del Ciclo seminariale Giustizia e letteratura (Law and Literature), IV edizione, 14 marzo 2013. Si ringrazia per l’aiuto scientifico il prof. Alessandro Barbero dell’Università del Piemonte Orientale, che generosamente e acutamente è stato prodigo di consigli nel nostro incontro a Vercelli. Si ringrazia altresì l’Associazione Amici della Fondazione Cavour di Santena, l’Archivio Cavour del Castello di Santena e l’Archivio di Stato di Torino, presso cui ho svolto parte della ricerca finalizzata alla stesura del presente saggio.
Addio, mia bella, addio:
l’armata se ne va;
se non partissi anch’io
sarebbe una viltà!
Bosi, 1848
1 Oltre la toponomastica
Immaginatevi, per un attimo, di camminare per le strade di qualsiasi città italiana, specialmente piemontese, e soffermare il vostro sguardo sulle targhe delle strade. Il tragitto che, ogni mattina, mi conduce da casa al Tribunale di Alessandria, mia città natale, è una teoria di simboli, personaggi e miti risorgimentali. Percorrendo Via Rattazzi, si arriva all’incrocio di Via Vochieri, patriota alessandrino, più in là ancora si trova Via Cavour, elegante strada ancora ottocentesca al termine della quale si erge Palazzo Ghilini, oggi sede della Prefettura, che vide uno degli incontri tra Cavour e Napoleone III. Via Cavour s’immette in Corso Lamarmora che, oltre Piazza Garibaldi, prosegue col nome di Corso Crimea. Una geografia simbolica abbastanza eloquente. Se ritenessimo la toponomastica espressione di un comune sentire della popolazione, potremmo concludere che il Risorgimento e i valori di cui è stato portatore siano condivisi dall’intera collettività. Probabilmente ciò era vero in periodi storici anteriori a quello attuale (1).
Da poco si sono concluse le celebrazioni per il centocinquantenario dell’Unità d’Italia, che, anziché farsi portatrici di una memoria condivisa, hanno mostrato limpidamente, da un lato, come il tessuto sociale sia lungi dall’essere unito, dall’altro, la drammatica assenza di un disegno politico. Tutti ricorderanno che, a pochi mesi dal 17 marzo 2011, il Governo non aveva ancora predisposto un programma per i festeggiamenti, tanto da essere richiamato formalmente dal Capo dello Stato, il quale, al contrario, fu encomiabile, poiché gestì in prima persona le celebrazioni, girando l’Italia e dando un significato intellettuale e storico preciso alla memoria del Risorgimento. Ricordo perfettamente, per esempio, che, il 10 giugno 2011, anniversario dei centocinquant’anni dalla morte di Cavour, Giorgio Napolitano, nonostante un malore, era al Castello di Santena, luogo in cui riposano le spoglie dello statista, per celebrare l’artefice dell’Unità italiana. A prescindere dall’attivismo del Quirinale, come si diceva, le celebrazioni hanno messo a nudo varie intenzioni di svilimento del Risorgimento. Tanto per far qualche esempio: il 17 marzo 2011, nel Consiglio Regionale del Piemonte, venne suonato l’inno di Mameli per ricordare la proclamazione dell’Unità d’Italia di centocinquant’anni prima. Celebrazione rovinata dall’uscita dall’aula del gruppo consigliare della Lega Nord, secondo cui l’Unità d’Italia avrebbe nuociuto al Nord. Peccato che nessuno abbia spiegato ai consiglieri che, proprio il Risorgimento e il movimento intellettuale e politico risorgimentale, specialmente piemontese e lombardo, sono stati certamente la più grande e recente espressione culturale del Nord Italia. Drammaticamente l’attacco al Risorgimento non viene solo da parte ‘padana’ ma, con uguale veemenza, anche da tesi meridionaliste che, quasi mai, sono storicamente attendibili (2).
Si sostiene, infatti, che il Sud fosse, prima dell’Unità, ricco, che l’Unità lo avrebbe condannato all’assenza di sviluppo attuale di alcune zone (3), che le regioni del Nord avrebbero pagato il loro debito pubblico con le casse del Regno delle Due Sicilie (4), et similia. Recentemente tutte queste tesi sono state confutate dalla storiografia, i cui esiti, però, difficilmente vengono portati a conoscenza del largo pubblico (5). Si deve ricordare, se ce ne fosse bisogno, che l’unificazione non ha nuociuto a nessuna delle regioni, visto che il pareggio di bilancio fu raggiunto l’ultima volta nella storia grazie al ministero di Quintino Sella e grazie allo sviluppo delle attività produttive in ragione delle quali aumentò prima dell’unificazione, nelle regioni del Nord, il debito pubblico. Alle tesi nordiste e meridionaliste si affiancano miriadi di opinioni: nostalgici del Granducato di Toscana (peraltro annesso all’Italia con referendum), indipendentisti di vario genere, neoborbonici, e persino coloro che rimpiangono lo Stato Pontificio. Da ultimo, lo Stato ha pensato bene di prendere posizione a favore del brigantaggio, senza una visione storica del tragico fenomeno e degli aspetti positivi della c.d. piemontesizzazione, finanziando il film “Noi credevamo” (6). Per chi non avesse visto la pellicola, sebbene il film fosse destinato a una celebrazione unitaria, parla di aspetti marginali dell’unificazione e si conclude con la disillusione del protagonista che constata il fallimento degli ideali di una generazione. Si noti che il fi lm è stato girato anche grazie al sostegno della Regione Piemonte che, pertanto, si è trovata a elargire moneta per la celebrazione dei briganti cilentani. Allora verrebbe da dire che, oltre alla toponomastica cittadina, del Risorgimento non rimane nulla e che forse sarebbe meglio non rimanesse nulla. Ma non sarà questo l’esito delle presenti riflessioni. È a questo punto che un discorso su giustizia e letteratura deve prendere avvio. Il giurista che si confronta con il testo letterario può svolgere un discorso di giustizia sul Risorgimento. Innanzitutto, giustizia intesa come restituzione corretta del dato storico-giuridico. Giustizia poi come individuazione dei valori risorgimentali. Giustizia, infine, come memoria viva di tali valori e loro proiezione nel diritto e nella politica attuale. La letteratura e la storia servono dunque al giurista per avere una visione più dettagliata della complessità dei fenomeni storici, per guardare agli sconfitti e ai vincitori, per capire le ragioni degli uni e degli altri. Il percorso di giustizia a cui è chiamato il giurista consiste quindi nell’abbandonare i vari «ismi» dei meridionalismi, indipendentismi, atteggiamenti mentali di semplificazione della realtà e pericolosi veicoli di tragiche ideologie (7).
2 Revisionismi
Dai saggi di Eraldo Bellini e Fausta Garavini (8) emerge limpidamente che patrioti, da una parte, e filoasburgici, dall’altra, in alcuni casi non furono oggettivi nel racconto dei processi ai carbonari. Ricostruire la verità storica nella duplice prospettiva risorgimentale e absburgica è già in sé una forma di giustizia, siccome permette una memoria condivisa di un evento essenziale della storia italiana (9)
Come accennato, è questo il presupposto di ogni discorso di giustizia: offrire una memoria condivisa e oggettiva, su cui possa svilupparsi il discorso pubblico. Ardua impresa nell’Italia attuale. Si può citare, a tal proposito, un caso lampante e allarmante. Nel 2012 è stato edito da Laterza I prigionieri dei Savoia, saggio storico di Alessandro Barbero (10).
In Val Chisone, Provincia di Torino, sorge la Fortezza di Fenestrelle, di certo uno dei migliori esempi di architettura militare, non solo sabauda. Il 6 luglio 2008 un gruppo di aderenti ai Comitati Due Sicilie salì a Fenestrelle per apporre una targa, che recita tuttora: «Tra il 1860 e il 1861 vennero segregati nella Fortezza di Fenestrelle migliaia di soldati dell’esercito delle Due Sicilie che si erano rifiutati di rinnegare il re e l’Antica Patria. Pochi tornarono a casa, i più morirono di stenti. I pochi che sanno s’inchinano». In effetti, se si naviga nella rete Internet, si trovano decine di siti o blog in cui Fenestrelle è considerata un lager ante litteram. Occorre dunque «inchinarsi» di fronte alla tragedia? Assolutamente no, perché di tragedia non si può parlare. Nel suo libro Barbero, grazie a un’analisi storica molto approfondita, dimostra che i soldati del Regno delle Due Sicilie che, dopo la resa di Capua, vennero trasferiti a Fenestrelle furono poco più di centocinquanta e solo quattro morirono per cause tra l’altro non dipendenti dalla detenzione. Nonostante l’attendibilità della ricostruzione storica, Barbero è stato vittima di minacce e di un vero e proprio boicottaggio, a dimostrazione della difficoltà di far memoria in Italia e del pericolo del revisionismo. Sovente, inoltre, si fa ricorso, per spiegare il Risorgimento e i suoi aspetti, a concetti novecenteschi. Ricorrente, per esempio, è l’affermazione che i mazziniani (tutti, peraltro) fossero terroristi. È questo un modo per non far giustizia alla storia, per applicare categorie generalizzanti e con una precisa genesi storica. L’utilizzo di una categoria, di un «ismo» qualunque serve per disumanizzare e per escludere le ragioni dell’altro. I vari revisionismi mostrano quindi un ‘tutti contro tutti’, dove non esistono le ragioni dell’altro, anzi dove l’altro viene disumanizzato e vilipeso nel tentativo di escluderlo dalla dialettica pubblica. In tutto questo c’è molto del Novecento, delle ideologie totalitarie e della logica del nemico. Come si vedrà in seguito, in tutto questo, invece, c’è poco Ottocento e poco Risorgimento.
Smitizzare, ironizzare e travisare sono tutti atteggiamenti violenti, che non rendono giustizia alla complessità della storia e dei suoi protagonisti. Si tratta allora di studiare se rimanga una verità sul Risorgimento e sui valori che discendono da esso.
3 L’idea risorgimentale di uomo
Si è dunque chiamati in queste pagine a far emergere i profili che compongono un’idea di giustizia che possa dirsi ispirata dall’esperienza risorgimentale. Si tende spesso a rimarcare la bontà della propria idea o della propria concezione del mondo accostando a essa un’idea palesemente sbagliata. È una sorta di fallacia del fantoccio, un errore di prospettiva, un utile espediente retorico (11). La tesi viene confermata non per la propria validità, ma per l’inesattezza di quella accostatale. Avviene come in certi romanzi o ricostruzioni storiche in cui la grandezza morale di un personaggio è dimostrata solo grazie alla scarsa statura di coloro che lo circondano. Il Risorgimento ci aiuta ad abbandonare tali espedienti e ci conduce in una ricerca del vero sempre dialettica e che non rinuncia alla complessità servendosi di banali semplificazioni. Verità che quindi si cerca sempre attraverso il confronto. I tipi umani che popolano l’esperienza risorgimentale si sottraggono, infatti, a facili luoghi comuni o stereo tipizzazioni (12).
La letteratura dell’epoca ce ne offre un’immagine complessa. Difficilmente si afferma il solo profilo eroico, o quello del debole e perdente che invece coesistono in una varia complessità di intrecci. Un brano di Pellico lo testimonia. Due giorni appresso, mio padre tornò. Io aveva dormito bene la notte, ed era senza febbre. Mi ricomposi a disinvolte e liete maniere, e niuno dubitò di ciò che il mio cuore avesse sofferto e soffrisse ancora. «Confido» mi disse il padre «che fra pochi giorni sarai mandato a Torino. Già t’abbiamo apparecchiata la stanza, e t’aspettiamo con grande ansietà. I miei doveri di impiego mi obbligano a ripartire. Procura, te ne prego, procura di raggiungermi presto.» La sua tenera e malinconica amorevolezza mi squarciava l’anima. Il fingere mi pareva comandato da pietà, eppure io fingeva con una specie di rimorso. Non sarebbe stata cosa più degna di mio padre e di me, s’io gli avessi detto: «Probabilmente non ci vedremo più in questo mondo! Separiamoci da uomini, senza mormorare, senza gemere, e ch’io oda pronunciare sul mio capo la paterna benedizione?» Questo linguaggio mi sarebbe mille volte più piaciuto della finzione. Ma io guardava gli occhi di quel venerando vecchio, i suoi lineamenti, i suoi grigi capelli, e non mi sembrava che l’infelice potesse aver la forza d’udire tali cose. Non potei dirgli il vero, né lasciarlo tralucere! La mia foggiata serenità lo illuse pienamente. Ci dividemmo senza lagrime. Ma ritornato nel carcere, fui angosciato come l’altra volta, o più fieramente ancora; ed invano pure invocai il dono del pianto (13).
Pellico cede al pietismo, come vorrebbe una parte di critica? Non pare. Certamente c’è una vena di sentimentalismo, peraltro legittima per via della condizione di carcerazione, ma quel che interessa di più è l’immagine che Pellico offre di sé. Pellico potrebbe, infatti, giocare all’eroe, che «da uomo» non cela la verità al padre. Non lo fa. Al contrario, mostra di sé un’immagine debole, straziata, certo colma di tenerezza nei confronti del padre, ma incapace di mostrarsi eroica. Un’immagine vera, quindi, complessa e articolata. Anche l’immagine che Fausta Garavini offre al lettore di Salvotti è certamente pluridimensionale. Salvotti è problematico, mai cede a certezze apodittiche, teme alle volte di essersi sbagliato. Non crede nell’infallibilità generale e soprattutto nella sua. Sia dalla lettura della vita di Antonio Salvotti, sia dalle Prigioni del Pellico emerge del resto una caratteristica comune dei due personaggi. Non si può dire che Salvotti sia innanzitutto italiano, forse non bisognerebbe spingersi a dir tanto, ma comunque l’essere italiano è parte della sua identità. Parte, peraltro, mai negata. Salvotti, di conseguenza, non si sente affatto estraneo alla sua epoca, né alla sua temperie culturale. Salvotti dapprima partecipa al mondo intellettuale milanese, diviene amico del Monti, poi approfondirà le motivazioni e le ragioni dei primordi del Risorgimento e della Carboneria. Salvotti non parte dall’idea che i carbonari siano il male, poiché si contrappongono al governo austriaco. Salvotti ritiene che la Carboneria sia pericolosa, siccome propugna ideali che non possono giovare all’Italia che, secondo il giudice trentino, dovrebbe rimanere con l’assetto politico della sua epoca, poiché il governo austriaco sarebbe il migliore ipotizzabile (14).
Salvotti dunque giudica la Carboneria, non la condanna aprioristicamente. Salvotti, comunque, non è cieco di fronte a quelli che ritiene difetti del proprio ordinamento e dedicherà la sua vita a eliminarli. Esempio di tale volontà è la proposta, accolta molti anni dopo la sua formulazione, dell’introduzione della pubblicità dei dibattimenti. Ecco, l’idea dell’indipendenza non si può vincere con le pene. Si può isolarla facendo cessare le cause che la producono … e una volta isolata potrà magari accendere qualche mente giovanile o visionaria, ma non potrà mai diventar popolare […]. Una delle cause per cui quest’idea si è sviluppata, e col tempo potrebbe dilagare, consiste in un sistema amministrativo e giudiziario non confacente al carattere degli abitanti del Regno, e contrasta con le loro ultime consuetudini. L’unificazione della legislazione e soprattutto dei metodi di procedura con quelli dell’Austria, non può essere accettata in Italia. La procedura segreta non si adatta a un popolo già abituato alla pubblicità dei dibattimenti… forma che d’altra parte consente alla naturale facondia degli italiani di dispiegarsi in una lingua di cui vanno giustamente orgogliosi. Si potrebbe cambiare in questo senso la legislazione, con un effetto benefico sullo spirito pubblico […] (15).
Certo, a ben guardare, la motivazione che spinge Salvotti ha forse una componente utilitaristica, poiché la pubblicità dei dibattimenti è considerata uno strumento di governo del popolo italiano. Dal ritratto che ne fa Fausta Garavini, Salvotti, inoltre, non emerge affatto come un perfido inquisitore, semmai come un funzionario molto scrupoloso. Anzi, Salvotti si caratterizza per il suo tratto umano nei confronti degli imputati (16). Forse per finta compassione o per celare la sua perfidia o per la soddisfazione discendente dal suo lavoro di inquisitore? No, semplicemente perché Salvotti, a prescindere dalla sua funzione, comprende che i suoi imputati non sono il nemico da disumanizzare, ma persone il cui pensiero deve essere compreso e studiato, prima di contestarlo, condannarlo e deprecarlo. Salvotti scava nella vicenda, interroga, collega le testimonianze, scarta le false piste, accumula nuove risultanze. Materiali inerti, la molla occulta del suo lavoro è un’altra: riconoscersi in Confalonieri, capirne il comportamento, penetrarne le intenzioni, entrare insomma nelle sue ragioni, le stesse che ha deciso di combattere. La funzione è indissociabile dall’uomo che la esercita, la sottomissione passiva del giudice alla legge è un’illusione. Solo la coscienza del giudice può dirimere gli elementi d’incertezza, colmare i vuoti del sistema giuridico, orientare la nebulosa degli indizi e delle presunzioni, nozioni ambigue, frammenti indefinitamente modulabili, perché vadano a costruire una verità probabile. Che cosa guida Salvotti a smascherare quell’imputato che si dichiara intimamente convinto della legittimità dei suoi piani, se non l’intima convinzione della sua colpevolezza? E mentre spiega le risorse della sua intelligenza in eleganti esercizi per stringere Confalonieri con le spalle al muro, e quello lotta all’ultimo sangue perché si gioca la vita, può forse, l’inquirente, non mettersi al suo posto? L’imputato davanti al giudice è un uomo davanti a un altro uomo, un essere che va compreso, preso con sé, assunto come un altro sé stesso. Un buon giudice è un buon giudice che dubita (17).
Salvotti, inoltre, come gli riconosce anche il Luzio, prevale col pensiero sull’imputato, non utilizza violenza, ma solo dialettica (18). Duello di pensiero, perso dal Salvotti, è quello col professor Romagnosi. Romagnosi sfrutta il codice austriaco per dimostrare che le prove raccolte contro di lui non son sufficienti e attacca Salvotti, imputandogli di essere stato anch’egli affiliato alla massoneria. Romagnosi vince, la prova non è sufficiente. Romagnosi che, peraltro, non serbò mai astio nei confronti di Salvotti (19).
Un anno dopo, tuttavia, su decreto di Francesco I gli venne tolto l’insegnamento: una sconfitta del pensiero nei confronti del potere. Salvotti non rispetta, poi, la norma per solo formalismo, crede che, grazie al rispetto della norma, si garantisca una giurisdizione considerata intrinsecamente giusta e migliore di quella francese, che si fonda unicamente sulla pubblicità dei giudizi e sull’intimo convincimento dei giudici. La legislazione austriaca, al contrario, esige la prova legale della colpevolezza, emergente dalla confessione del reo, dai testimoni e dalla deposizione dei correi. Tornando a Pellico, la lettura offerta da Eraldo Bellini sfata l’opinione del Pellico solo come uomo dei buoni sentimenti cristiani, che perdona tutti indistintamente. Come d’altronde viene fortemente messa in dubbio l’idea delle Prigioni come melenso scritto di chi vuol mostrare carità cristiana anche verso i propri ‘nemici’. Le Prigioni, soprattutto nella parte dedicata alla carcerazione nello Spielberg, si caratterizzano per una prosa asciutta, poco incline al sentimentalismo. Non inganni il famoso dono della rosa di Maroncelli, gesto sì teatrale, ma a conclusione di un episodio molto realistico e intenso, che tra l’altro è specchio fedele delle condizioni di vita, a tratti certamente disumane, nello Spielberg (20). Chi vede nel Pellico una non sincerità deve quindi ricredersi (21). Pellico dunque non perdona solo per spirito cristiano, o per una carità senza verità, ma perché ha in carcere un’intuizione essenziale. Quando vede che il carceriere milanese Tirola non è affatto disumano quanto potrebbe sembrare, esclama: «Mi viene, buon uomo, un pensiero che non ho mai avuto: che si possa fare il carceriere ed essere di ottima pasta». Il Tirola risponde a Pellico: «Il mestiere non fa niente, signore. Al di là di quel voltone ch’ella vede, oltre il cortile, v’è un altro cortile ed altre carceri, tutte per donne. Sono … non occorre dirlo … donne di mala vita. Ebbene, signore, ve n’è che sono angeli, quanto al cuore. E s’ella fosse secondino…» (22). Intuizione che diviene certezza con l’incontro e la consuetudine di vita allo Spielberg con il carceriere Schiller. Ei passeggiava lentamente su e giù, agitando quel villano mazzo di grosse chiavi, ed io con occhio irato mirava la sua gigantesca, magra, vecchia persona; e, ad onta de’ lineamenti non volgari del suo volto, tutto in lui mi sembrava l’espressione odiosissima d’un brutale rigore! Oh come gli uomini sono ingiusti, giudicando dall’apparenza e secondo le loro superbe prevenzioni! Colui ch’io immaginava agitasse allegramente le chiavi per farmi sentire la sua trista podestà, colui ch’io riputava impudente per lunga consuetudine, volgea pensieri di compassione e certamente non parlava a quel modo, con accento burbero, se non per nascondere questo sentimento. Avrebbe voluto nasconderlo, a fine di non parer debole e per timore ch’io ne fossi indegno; ma nello stesso tempo, supponendo che forse io era più infelice che iniquo, avrebbe desiderato di palesarmelo.
Noiato della sua presenza, e più della sua aria da padrone, stimai opportuno d’umiliarlo, dicendogli imperiosamente, quasi a servitore: «Datemi da bere.» Ei mi guardò, e parea significare «Arrogante! Qui bisogna divezzarsi dal comandare». Ma tacque, chinò la sua lunga schiena, prese in terra la brocca, e me la porse. M’avvidi, pigliandola, ch’ei tremava, e attribuendo quel tremito alla sua vecchiezza, un misto di pietà e di reverenza temperò il mio orgoglio. «Quanti anni avete?» gli dissi con voce amorevole. «Sessantaquattro, signore: ho già veduto molte sventure mie e altrui.» Questo cenno sulle sventure sue ed altrui fu accompagnato da nuovo tremito nell’atto ch’ei ripigliava la brocca; e dubitai fosse effetto, non della sola età, ma di un certo nobile perturbamento. Siffatto dubbio cancellò dall’anima mia l’odio che il suo primo aspetto m’aveva impresso. «Come vi chiamate?» gli dissi. «La fortuna, signore, si burlò di me, dandomi il nome d’un grand’uomo. Mi chiamo Schiller.» […] «Caporale qual sono» diceva egli «m’è toccato per luogo di riposo il tristo ufficio di carceriere: e Dio sa, se non mi costa assai più rincrescimento che il rischiare la vita in battaglia!» Mi pentii di avergli dimandato con alterigia da bere. «Mio caro Schiller» gli dissi, stringendogli la mano «voi lo negate indarno, io conosco che siete buono, e poiché sono caduto in quest’avversità, ringrazio il cielo di avermi dato voi per guardiano.» Egli ascoltò le mie parole, scosse il capo, indi rispose, fregandosi la fronte, come uomo che ha un pensiero molesto: «Io sono cattivo, o signore; mi fecero prestare un giuramento, a cui non mancherò mai. Sono obbligato a trattare tutti i prigionieri senza riguardo alla loro condizione, senza indulgenza, senza concessione di abusi, e tanto più i prigionieri di Stato. L’imperatore sa quello che fa; io debbo obbedirgli.» «Voi siete un brav’uomo, ed io rispetterò ciò che riputate debito di coscienza. Chi opera per sincera coscienza può errare, ma è puro innanzi a Dio.» «Povero signore! Abbia pazienza, e mi compatisca. Sarò fero ne’ miei doveri, ma il cuore … il cuore è pieno di rammarico di non poter sollevare gli infelici. Questa è la cosa ch’io volea dirle.» Ambi eravamo commossi. […] Uscì, richiuse la porta, ed io mi sdraiai sulle dure tavole, febbricitante sì, e con forte dolore al petto, ma meno fremente, meno nemico degli uomini, meno lontano da Dio (23). Intuizione che, d’altronde, è centrale nelle Prigioni, come si afferma nell’incipit della prima edizione.
Ho scritto queste memorie per vanità di parlar di me? Bramo che ciò non sia, e per quanto uno possa di sé giudice costituirsi, parmi di aver avuto alcune mire migliori: – quella di contribuire a confortare qualche infelice con l’esponimento de’ mali che patii e delle consolazioni ch’esperimentai essere conseguibili nelle somme sventure; – quella di attestare che in mezzo a’ miei lunghi tormenti non trovai pur l’umanità così iniqua, così indegna d’indulgenza, così scarsa di egregie anime, come suol venir rappresentata; – quella d’invitare i cuori nobili ad amare assai, a non odiare alcun mortale, ad odiar solo irreconciliabilmente le basse finzioni, la pusillanimità, la perfidia, ogni morale degradamento; – quella di ridire una verità già notissima, ma spesso dimenticata: la Religione e la Filosofi a comandare l’una e l’altra con energico volere e giudizio pacato, e senza queste unite condizioni non esservi né giustizia, né dignità, né principii securi (24).
Pellico, come e forse più di Salvotti, riconosce quindi un’umanità nell’altro da sé. Pellico comprende, infatti, le ragioni dell’agire dell’altro. Si può dunque affermare che Salvotti e Pellico abbiano in comune una certa idea di umanità. L’altro da sé è in primo luogo portatore di ragioni che devono essere comprese. Ragioni che si possono trovare in qualsiasi uomo e in qualsiasi condizione di vita. Pellico e Salvotti, grazie a ciò, giungono a riconoscere un’umanità nell’altro, che non è un nemico senza volto e senza ragioni. Una tale idea di uomo appare tipica del periodo risorgimentale (25), come illustrato da un aneddoto, che mi è stato riferito. Tra la prima e la seconda Guerra di Indipendenza, nelle campagne piemontesi e lombarde bagnate dal Ticino iniziò a diffondersi una canzone popolare, ancor oggi molto nota: La bella Gigogin (La bella Teresa). La bella Gigogin è l’Italia, che deve sposarsi, quindi unificarsi. «Per non mangiar polenta» significa liberarsi dal dominio austriaco. La bandiera austriaca era gialla come la polenta. «Dàghela avanti un passo» (fai un passo avanti) è un’esortazione a Vittorio Emanuele II a entrare in guerra contro l’Austria. I soldati austriaci di stanza nel Lombardo-Veneto sentirono talmente tante volte questo canto che iniziarono a cantarlo, anche prima della battaglia di Solferino. Alcuni sostengono perché non capivano le parole, ma non è verosimile, visti i tanti italiani nell’esercito austriaco. Più probabilmente, anche in questo caso, per l’austriaco l’italiano non è il nemico anonimo e spersonalizzato, ma un soggetto in cui si riconosce un’identità e una consuetudine di vita, dalla canzone popolare fino alla condivisione di valori simili, come dimostrano le fi gure del Pellico e di Salvotti. Ben inteso, con questo non si vuol sostenere che vengano condivisi anche gli ideali politici. Pellico non si riconciliò mai con il governo austriaco, di cui non riconobbe mai la legittimità. Non parlò mai di Giustizia, riferendosi all’ordinamento austriaco, ma di «forza», non riconoscendo così la legittimità del potere che lo aveva imprigionato. Infatti, Pellico ritenne sempre che «dove un governo è malvagio, bisogna o emigrare, o star sott’esso, senza prendere parte alle sue colpe ed esercitando tutte le possibili virtù, anche quella d’esporsi a perire, prima di farsi reo di alcuna iniquità» (26).
Anche Salvotti non condivise nulla delle idee del Risorgimento italiano. È quindi il caso di uscire da un equivoco. Il rimanere convinti della propria visione politica non rende ipocrita l’apertura verso i propri oppositori. Come si è detto, Pellico individuò un’umanità e un pensiero nei suoi giudicanti e nelle persone che incontrò, ma non riconobbe mai la legittimità del loro potere (27). Se dunque nelle Prigioni Pellico si guarda bene dal rendere l’immagine dello Spielberg meno tragica di quel che effettivamente fosse o non riconobbe un proprio sbaglio, è segno di coerenza e di un progetto politico, come sostiene Eraldo Bellini (28), più che d’ipocrisia (29). Non è quindi il caso di stupirsi o di biasimare il fatto che le Prigioni divennero strumento di propaganda politica. Rispetto dell’altro e riconoscimento di un suo pensiero non debbono certo impedire di professare le proprie idee. Al contrario, il confronto con ‘l’altro da sé’ serve per confermare e migliorare le proprie convinzioni. Questo ‘umanismo’ risorgimentale si lega a un’idea di giustizia, contrapponendosi alla tendenza – da cui non è immune la pratica giuridica – a stigmatizzare la diversità come ‘non umana’, a costruire come nemici i portatori di idee non condivise. In questo può ritrovarsi una stretta analogia tra il Risorgimento e la Resistenza: due esperienze contrapposte non solo alle ingiustizie, ma anche alle varie forme di totalitarismo, alla negazione del dissenso e alla disumanizzazione di ogni diversità (30).
4 Il Risorgimento come pensiero e come idea di giustizia.
Quale, dunque, l’idea di giustizia che può essere colta almeno in parte nell’esperienza risorgimentale e che può parlare al giurista di oggi? In effetti nel pensiero risorgimentale è ben presente il rapporto tra diritto e giustizia e si avverte la necessità di un equilibrio tra esigenze giuridico-politiche e istanze di giustizia sostanziale. Ritorniamo per un attimo a I prigionieri dei Savoia di Barbero. Il necessario arruolamento degli ex soldati borbonici nei ranghi dell’esercito italiano dopo la capitolazione di Capua generava molti problemi, non ultimi quelli della fedeltà al nuovo re e dell’obbedienza ai superiori militari. La fedeltà e l’obbedienza non potevano certo essere garantite da tutti, soprattutto dai più fedeli al re borbone. Tuttavia, chiunque avesse abbandonato l’esercito avrebbe commesso il reato di diserzione. Si deve ricordare che nella legislazione sabauda esisteva una differenza notevole tra tentata diserzione e diserzione. Solo quest’ultima era considerata, infatti, reato. Il tentativo di diserzione era invece un illecito disciplinare. Perché si configurasse il reato di diserzione era necessaria una denuncia, che poteva essere presentata solo ventiquattr’ore dopo che si era constatata l’assenza senza permesso (31). Dal momento di presentazione della denuncia decorrevano cinque giorni in cui il soldato poteva ripresentarsi senza incorrere in sanzioni. La magistratura torinese tra il 1861 e il 1862 si pronunciò sovente su tale materia, seguendo un preciso orientamento. Infatti, vi sono pochissime condanne per diserzione inflitte a soldati meridionali. La maggior parte delle sentenze sono di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, si direbbe utilizzando l’attuale terminologia giuridica. Un esempio ci è offerto dalla vicenda giudiziaria di cinque soldati napoletani del primo reggimento fanteria, imputati di diserzione per essersi allontanati dal loro corpo d’armata, senza giustificato motivo, il 10 gennaio 1861. I cinque militari vennero denunciati il giorno seguente, ma emerse che fossero già stati fermati dai carabinieri prima che venisse sporta denuncia. Denuncia che tuttavia era valida e presentata nei termini. La questione giuridica era se potesse configurarsi la diserzione. Correttamente il Tribunale di Torino, nonostante la validità della denuncia, con sentenza del 9 febbraio 1861 dispose il non luogo a procedere. Infatti, nonostante la denuncia fosse valida e sporta nei termini e palese la non volontarietà della presentazione alle forze dell’ordine dei disertori, lo stato di diserzione doveva considerarsi già cessato nel momento in cui venne denunciato il fatto (32).
Situazione più complessa, ma con soluzione analoga a quella precedente, si verificò a causa della diserzione, previo complotto, di nove soldati del 25° reggimento fanteria che si erano allontanati da Chivasso dov’erano stanziati. La denuncia venne subito presentata. La magistratura torinese fece leva su questo argomento per mandare assolti i militari, siccome al momento della presentazione della denuncia non era ancora spirato il termine dilatorio di ventiquattr’ore (33). Ci si accorge immediatamente che, se nel primo caso prevalse la sostanza sulla forma, cioè l’effettività dello stato di diserzione sui requisiti formali del reato, in questo secondo caso furono invece questi ultimi e la loro disciplina a prevalere. Sempre con argomentazioni giuridiche corrette, peraltro. L’orientamento è dunque sempre stato lo stesso: vigilare sulla corretta applicazione della norma in modo favorevole al reo, per evitare che il rigore della sanzione penale potesse esasperare la situazione del corpo militare già in agitazione. L’orientamento giurisprudenziale fu ancora più evidente in altri due casi. Angelo Caravelli, ex soldato borbonico, disertò il 2 maggio 1861 e si costituì l’8 maggio, ben dopo i cinque giorni previsti per la possibile presentazione alle forze dell’ordine. Il Tribunale di Torino in questo caso accolse la tesi difensiva dell’imputato che sosteneva di essersi allontanato e costituito dopo i cinque giorni poiché non trovava la strada e si era perso (34).
Ancora: Gaetano Grosso, casertano, stando alla denuncia, si allontana da Cuneo il 14 aprile 1861. Si costituisce al Sindaco di Garessio il 20 di aprile. Il Tribunale, assolvendo l’imputato, osserva che non vi era nessun riscontro fattuale che costui si fosse assentato il 14. Si richiede dunque conferma a quanto sostenuto nella denuncia. Nuovamente la sostanza prevale sulla forma. In un altro caso, l’imputato si consegnò il sesto giorno. Qui si pose, invece, il problema di stabilire se i cinque giorni dovessero essere considerati liberi. Si scelse quest’orientamento e l’imputato fu assolto. In questi casi non si giunse mai alla disapplicazione della norma e la norma incriminatrice (con le relative ‘condizioni obiettive di punibilità’), venne interpretata secondo il criterio del favor rei in caso di dubbio sulla sua applicabilità. Ma non tardò la risposta della politica e del potere, che tentò di arginare questa interpretazione. Si stabilì, con una circolare, che il comandante del reparto dovesse denunciare dopo le ventiquattr’ore la diserzione, trasformando in obbligo quella che prima era una facoltà. L’orientamento della giurisprudenza appare coerente con un’idea di giustizia che attraversa l’esperienza risorgimentale: lo sforzo di conciliare, in modo talora lungimirante, il rispetto della norma, l’attenzione alla dimensione umana dei soggetti protagonisti della vicenda criminale e le finalità dell’ordinamento. Un’idea non certo espressa dalle sole sentenze della magistratura militare piemontese in tema di diserzione, ma presente in larga parte della società del tempo (35).
Essa, ad esempio, fa da sfondo all’opera che Stefano Solimano ha dedicato all’unificazione giuridica dello Stato italiano (36). Già un decennio prima dell’Unità d’Italia i giuristi piemontesi e lombardi iniziarono un serrato dibattito sui maggiori periodici giuridici in merito all’unificazione legislativa. Il problema si pose in tutta la sua portata all’indomani della seconda Guerra di Indipendenza. Non che già prima del 1859 non se ne discutesse, anche perché il Regno sabaudo ospitava molti esuli lombardi che fungevano da ponte tra le due culture giuridiche. A seguito dell’annessione della Lombardia, i giuristi piemontesi e lombardi prestarono grande attenzione alle loro diverse tradizioni giuridiche. L’idea, di discendenza giobertiana, era che il nuovo codice non potesse che essere il frutto delle varie tradizioni giuridiche italiane. Come si nota, anche in questo caso, l’esperienza risorgimentale insegna che ogni riforma legislativa ha come presupposto la necessaria apertura nei confronti delle ragioni dell’altro. Occorre ricordare che per l’unificazione legislativa prevalse, tuttavia, la tesi opposta, volta a estendere la legislazione sabauda mediante il nuovo codice civile del 1865. Probabilmente, il veloce mutare della situazione politica e l’assenza dal giugno del 1861 di una guida politica adatta, portarono a scegliere la via dell’assimilazione giuridica, forse ritenendo che la portata simbolico-politica della stessa potesse essere strumento idoneo per l’unificazione del popolo. Un’altra imposizione del potere sul pensiero. L’esito di questo dibattito giuridico non vanifica, ma, anzi, conferma che, fino al momento dell’Unità, prevalse un ideale di giustizia, che opponeva il pensiero e la riflessione sia al formalismo, sia alla violenza, senza sacrificare incondizionatamente l’uomo e la società al rigore della norma. È del resto quest’idea che sosteneva l’aspirazione a un regime costituzionale, che si reggesse sul libero dibattito pubblico (sul pensiero, quindi) e sull’autogoverno del popolo. L’aspirazione di giustizia dei carbonari e di chi li seguì nel corso del Risorgimento si presta anche a una favorevole lettura penalistica. Il sistema penale austriaco (37) era ben lungi dall’essere il migliore possibile, checché ne dicesse Salvotti. Ricordiamo che tutti i carbonari, ad esempio, non vennero giudicati da un giudice precostituito, bensì da un giudice speciale: la Commissione di cui fece parte Salvotti. Inoltre, la fattispecie di alto tradimento, di cui al § 52 cod. pen. aus., non rispettava certamente, nella sua formulazione, la necessaria precisione delle norme penali (38). Era talmente lata la formulazione della norma che chiunque, come accadde per esempio a Romagnosi, avrebbe potuto essere imputato di Carboneria. Tant’è che anche il legislatore austriaco, comprendendo le problematicità della formulazione della norma, nel 1852, con il § 58 del nuovo codice criminale, tentò di procedere a una più precisa formulazione. Da non trascurare, inoltre, che venne altresì emanato, il 29 agosto 1820, un editto per contrastare la Carboneria con cui si estendeva l’applicazione della fattispecie di alto tradimento a tutti coloro che, avuta cognizione delle attività carbonare, non le avessero denunciate: un’evidente istigazione alla delazione. Peraltro, la normativa estendeva la punibilità per tutti i fatti pregressi. Solo in teoria, infatti, la normativa non era retroattiva, poiché obbligava a denunciare anche i fatti appresi nel passato, risolvendosi dunque nell’avere efficacia retroattiva. Ricordiamo anche che, per quanto la confessione fosse la prova principe, la stessa doveva essere perseguita a ogni costo dall’inquisitore, anche con lo strumento del bastone (art. 364 c.p. aus.). È vero: Salvotti non utilizzò mai tale strumento, vittoria del pensiero del singolo sull’incapacità di evoluzione di un sistema lontano dal paradigma della giustizia come pensiero. Salvotti comprendeva questi aspetti, come anche la durezza della detenzione presso lo Spielberg, ed è per questo che tentò di chiedere, seppur implicitamente, clemenza per i condannati. Come chiese di riformare il codice, ma sotto il regno conservatore e con tratti di assolutismo di Francesco I d’Austria, ciò non era pensabile. Altra vittoria del potere sulla giustizia.
5 Lo spirito del Risorgimento per il presente e per il futuro
Il pensiero risorgimentale contribuì a formare quello europeo, e ciò non è solo motivo di orgoglio, ma anche di riflessione. Da un recente libro di Rusconi (39) emerge come la politica cavouriana sia stata l’espressione di un pensiero opposto alla violenza e all’ideologia: un tratto tipico dell’epopea risorgimentale che affascinò gli stranieri e fece dell’Italia un modello da seguire. Cavour fu, talora, pragmatico e campione della Realpolitik nel controllare strettamente il Parlamento. Altre volte si dimostrò, invece, un campione del liberalismo parlamentare, tanto da suscitare ammirazione nella liberale Inghilterra che seguiva con molto interesse le vicende piemontesi prima, italiane poi. Anche il pensiero politico di Pellico merita considerazione, con buona pace di Monaldo Leopardi (40) e dei suoi attuali seguaci. Un pensiero che aiutò il popolo italiano ad abbandonare una deleteria logica degli opposti. Ideali risorgimentali e cristianesimo in Pellico non sono più nettamente separati visto che l’impegno cristiano è prestato a favore della causa e della politica nazionale. Il Risorgimento espresse la giustizia di una legittimazione popolare della politica, non bastando la sola competenza o efficienza dei governanti. Alla politica e al diritto spetta però anche il compito di sviluppare la capacità di pensiero e di accettazione della diversità. In apertura si è citato il ritornello della canzone popolare Addio mia bella addio di Carlo Alberto Bosi. A una prima lettura, potrebbe sembrare consueta espressione di un romanticismo un po’ datato. Nella canzone, invece, si parla di viltà e di libertà. Studiare il Risorgimento ci aiuta a recuperare un senso di questi concetti e a renderlo vivo. Anche per l’uomo di oggi sarebbe, infatti, vile non partecipare a quella aspirazione di libertà che caratterizzò il Risorgimento, che non fu un’epopea melodrammatica e melensa fatta da uomini piccoli, ma una tensione, sicuramente eroica, al raggiungimento della giustizia attraverso il pensiero.
NOTE
(1) Lo spirito risorgimentale emergeva, fino a poco tempo fa, anche in contesti lontani dalla storiografia e dalla letteratura, a dimostrazione di un sentimento profondo, quasi immanente nella popolazione e nei luoghi delle Guerre di Indipendenza. Ad esempio la celebre canzone del grande cantautore piemontese di Ricaldone Luigi Tenco, Ciao amore ciao ha un’origine e un’ispirazione risorgimentale. La versione originale, ancora reperibile, s’intitolava Li vidi partire, ed era dedicata ai soldati delle Guerre di Indipendenza, specialmente a quelli che combatterono a Curtatone Montanara. Leggendola in questa prospettiva, la canzone mostra un’immedesimazione dell’Autore col suo dolore esistenziale per l’impossibilità di un ritorno in coloro che abbandonarono «i campi di grano» e «le strade bianche come il sale» per combattere e mai più tornare.
(2) Di recente tale considerazione è stata ripresa da un articolo, in risposta alla lettera di un lettore, da S. Romano, La Camorra dopo l’Unità vista da uno storico francese, «Corriere della Sera», 2 giugno 2013, p. 29. In questo articolo, prendendo spunto da Marc Monnier, La Camorra, Firenze 1863, si spiega in poche battute che il brigantaggio non fu quel fenomeno romantico che si vorrebbe in alcuni contesti, ma nacque quando una minoranza di ex sudditi borbonici iniziò ad assoldare malviventi del Regno delle Due Sicilie per combattere l’unificazione del Regno. Nello stesso articolo si fa luce sulla brutalità di alcuni briganti come Carmine Crocco, ritenuti da una parte dell’opinione pubblica, e non si sa per quale motivo, degni di essere protagonisti di telefilm: Il generale dei briganti, di P. Poeti (Italia: 2012, durata 198’).
(3) Riguardo al divario sussistente tra Nord e Sud in merito a industria, infrastrutture, e scolarizzazione, si vedano G. Pescosolido, L’economia siciliana nell’unificazione italiana, «Mediterranea», 2010, 19, pp. 217-234; V. Zamagni, Dalla periferia al centro. La seconda rinascita economica dell’Italia, 1861-1981, Bologna 1990; SVIMEZ, Un secolo di statistiche italiane. Nord e Sud 1861-1961, Roma 1961, p. 795. Tali fonti mettono in risalto l’esistenza di un grande divario tra il Nord produttivo e alfabetizzato e il Sud, regione non ancora industrializzata e con un enorme problema di alfabetizzazione.
(4) Tesi sostenute da D. Fausto, Lineamenti dell’evoluzione del debito pubblico in Italia (1861- 1961), in http://www.delpt.unina.it/stof/15_pdf/15_6.pdf.
(5) Il debito più alto del Nord è un fenomeno già spiegato da L. Einaudi, Miti e paradossi della giustizia tributaria, Torino 1959, p. 274: «la finanza borbonica provvedeva alle opere pubbliche atte a dare un incremento all’economia del paese entro i limiti dell’andamento spontaneo delle entrate al di sopra delle esigenze delle spese ordinarie, sì da far credere che l’opera fosse dovuta a generosità del sovrano; la finanza cavouriana non temeva di anticipare con prestiti l’incremento del gettito tributario o lo provocava con opere di ferrovie, di canali, di navigazione atte ad accrescere la produttività del lavoro nazionale». Quindi non si nega che il debito fosse più alto, ma si osserva che fosse giustificato dalla creazione di attività produttive, che peraltro servirono per sviluppare l’economia, porre le basi per uno Stato industrializzato e raggiungere il pareggio di bilancio. Pareggio di bilancio che non si ebbe, come taluni vorrebbero, con le riserve auree delle Due Sicilie, di certo non bastevoli allo scopo. Il debito sabaudo era dunque un debito produttivo, che servì a pagare anche il debito improduttivo del Mezzogiorno. Se ci fosse bisogno di conferma dei benefici economici dell’unificazione, si veda Pescosolido, L’economia siciliana nell’unificazione italiana, p. 234, secondo cui la Sicilia certamente ebbe notevoli benefici grazie all’unificazione
(6) Noi credevamo, di G. De Cataldo (Italia: 2010, durata 170’).
(7) Sull’atteggiamento mentale insito in ogni «ismo», si rinvia alla profonda riflessione di G. Forti, La scomodità dello specchio, introduzione a C. de Maglie, I reati culturalmente motivati, Pisa 2010, pp. V ss.
(8) E. Bellini, Silvio Pellico e «Le mie prigioni», supra; F. Garavini, In nome dell’Imperatore, supra. Sulla fi gura e l’opera di Pellico si rinvia a E. Bellini, Manzoni e Pellico, in AA.VV., Manzoni tra due secoli, Milano 1986, Id., Pellico, Foscolo e la ‘donna gentile’, «Aevum», 1997, pp. 769 ss. e S. Pellico, Le mie prigioni (1832), a cura di E. Bellini, Brescia 1985.
(9) Il racconto del Risorgimento grazie a questa duplice prospettiva caratterizza anche le opere di C. Cipolla - M. Bertaiola (a cura di), Sul crinale. La battaglia di Solferino e SanMartino vissuta dagli italiani, Milano 2009 e C. Cipolla - P. Dusi (a cura di), L’altro crinale. La battaglia di San Martino e Solferino vista dal versante austriaco, Milano 2009.
(10) A. Barbero, I prigionieri dei Savoia, Roma-Bari 2012
(11) Sulla retorica si veda B. Mortara Garavelli, Manuale di retorica, Milano 2003 ed Ead., Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani, Torino 2001.
(12) Forse troppa ironia viene usata da F. Garavini, In nome dell’Imperatore, Sommacampagna (Vr) 2009, pp. 89-91 su Carlo Alberto di Savoia Carignano e sugli avvenimenti del marzo 1821. Il ritratto di Carlo Alberto è quello del c.d. «Re Tentenna», impietoso e non corrispondente al vero. È noto che Carlo Alberto, all’epoca, non fosse re e dovesse fare i conti con il reazionario Carlo Felice. Vicende note a cui bisognerebbe dar spazio, se non altro per offrire un’immagine storica degli avvenimenti risorgimentali. La rettitudine e la statura morale di Carlo Alberto, peraltro, se ce ne fosse bisogno, saranno confermati dalle sue decisioni durante la prima Guerra di Indipendenza, dove rimase solo a combattere gli austriaci, abbandonato dagli alleati. L’ironia non è un buon mezzo, perché colpisce tutti indistintamente. Se ne potrebbe fare anche su Pellico e ancor di più forse su Salvotti, dipinto a tratti come un eroe fin troppo borghese. Così non capiremmo, però, la persona, semplificheremmo l’uomo che ha sempre aspetti di grandezza e piccolezze, che tuttavia rendono l’individuo vivo. Occorre tuttavia sottolineare che l’opera menzionata non è un trattato storico e, pertanto, è ammissibile l’utilizzo di tale ironia, anche se impedisce di conoscere a fondo i personaggi.
(13) S. Pellico, Le mie prigioni (1832), Milano 1986, pp. 56-57.
(14) Garavini, In nome dell’Imperatore, p. 59: «Questi Carbonari, prima hanno osannato l’Austria che li liberava dalla tirannide bonapartesca, e ora vedono gli austriaci come il fumo della legna verde. Però nessuno ha ancora provato che il Lombardo-Veneto senza austriaci starebbe meglio. Anzi, questo è il miglior governo che ci sia in Italia».
(15) Ibi, pp. 183-184.
(16) Si veda, per il trattamento carcerario riservato a Pellico e Maroncelli, A. Luzio, Il processo Pellico-Maroncelli. Secondo gli atti officiali segreti, Milano 1903, p. 98.
(17) Garavini, In nome dell’Imperatore, p. 129.
(18) Luzio, Il Processo Pellico-Maroncelli, p. 97.
(19) Ibi, p. 139.
(20) Si veda, sul punto, Luzio, Il processo Pellico-Maroncelli, pp. 527 ss., il quale ricorda che neppure il governo austriaco riuscì nell’intento di dimostrare che le condizioni di prigionia allo Spielberg fossero tollerabili.
(21) Salvo concordare con Monaldo Leopardi e il suo giudizio su Pellico «Penna avvelenata intinta nell’acqua santa». Monaldo, reazionario e sostenitore del trono e dell’altare, ovviamente temeva che l’ideale risorgimentale si sposasse con la fede cristiana, poiché le conseguenze per il vecchio sistema politico sarebbero state rivoluzionarie. La citazione di M. Leopardi è tratta da Garavini, In nome dell’Imperatore, p. 197.
(22) Pellico, Le mie prigioni, p. 37.
(23) Ibi, pp. 141-144
(24) Ibi, p. 27.
(25) Si veda, a tal proposito, la celebre poesia di Giuseppe Giusti, Sant’Ambrogio nei cui versi il poeta sembra parlare di tale visione dell’altro da sé: «A dura vita, a dura disciplina, / muti, derisi, solitari stanno, / strumenti ciechi d’occhiuta rapina, / che lor non tocca e che forse non sanno; e quest’odio, che mai non avvicina / il popolo lombardo all’alemanno, / giova a chi regna dividendo, e teme / popoli avversi affratellati insieme».
(26) Pellico, Le mie prigioni, cap. IV aggiunto, p. 257 (si fa riferimento all’edizione curata da E. Bellini e citata alla nota 8).
(27) Da parte austriaca, forse, l’apertura verso l’altro avrebbe dovuto portare a una maggiore consapevolezza del movimento risorgimentale italiano. Molto più interesse ci fu, per esempio, per il popolo magiaro. Questo probabilmente travolse il governo absburgico, che non comprese il pericolo effettivo del Risorgimento, fatta eccezione per il principe Metternich che, poco prima di morire, sconsigliava il famoso ultimatum al Piemonte del 19 aprile 1859. Insomma, era forse un po’ irrealistico ‘spegnere’ il Risorgimento italiano inserendo nel codice la pubblicità dei dibattimenti.
(28) Bellini, Silvio Pellico e «Le mie prigioni», supra, p. 57.
(29) Non si concorda dunque con Garavini, In nome dell’Imperatore, pp. 196-197.
(30) H. Arendt, Le origini del totalitarismo (1951), trad. it. di A. Guadagnin, Torino 2004.
(31) Barbero, I prigionieri dei Savoia, pp. 197 ss.
(32) Ibi, p. 210.
(33) Ibi, p. 211.
(34) Ibi, p. 212
(35) Un’attenta lettura storica mette in luce una delle false idee in merito al Risorgimento: quest’ultimo sarebbe stato un movimento culturale elitario, guidato da una cerchia ristretta di intellettuali e politici, perlopiù sabaudi. Al contrario, il mondo intellettuale meridionale già da un decennio prima dell’Unità rifletteva e si preparava a tale eventualità. Altra inesattezza è che partecipò al movimento risorgimentale solo la classe sociale più agiata, visto il grande numero di rivolte popolari.
(36) S. Solimano, ‘Il letto di Procuste’. Diritto e politica nella formazione del codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861), Milano 2003, pp. 9 ss.
(37) Sul punto si rinvia integralmente al saggio di S. Solimano, I due colori della giustizia. Rappresentazioni della repressione del dissenso politico in Austria e in Francia nel XIX secolo, supra.
(38) «Commette un delitto di alto tradimento: a) chi offende la personale sicurezza del Capo Supremo dello Stato; b) chi intraprende qualche cosa tendente a fare una violenta rivoluzione nel sistema dello Stato, o ad attirare contro lo Stato un pericolo da fuori, o ad accrescerlo, sia che ciò venga fatto in pubblico, o in segreto; da persone separate, o collegate assieme; colla macchinazione, col consiglio o col proprio fatto; colla forza dell’armi e senza; colla comunicazione di segreti conducenti a tal fi ne, o di trame ad esso rivolte: coll’istigazione, leva di gente, soccorso o con qualunque altra azione diretta a simile intento».
(39) G.E. Rusconi, Cavour e Bismarck. Due leader fra liberalismo e cesarismo, Bologna 2010.
(40) Vedi, sopra, nota 21.