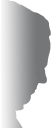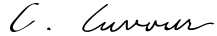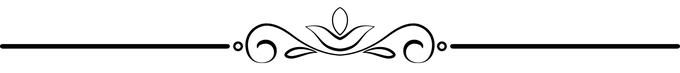Relazione di Rosanna Roccia il 6 novembre in Sala Rossa del municipio di Torino
Nel 1911, cinquantenario della morte dello statista avvenuta il 6 giugno 1861, meno di tre mesi dopo la proclamazione di Vittorio Emanuele II re d’Italia, il ricordo di Cavour in questa Sala fu affidato al sobrio medaglione scolpito da Edoardo Rubino, che ne perpetua tutt’oggi la memoria. Si trattava, e si tratta, di un omaggio non al “padre della patria”, ma, come recita la didascalia, al consigliere comunale cui le elezioni del 7 novembre 1848, le prime della storia amministrativa di Torino scaturite dalle riforme statutarie, avevano spalancato le porte dell’aula al servizio della città natale.
Il 1848 per Cavour e per lo Stato era stato l’inizio di una stagione nuova, in cui il “prima” aveva avuto una parte non secondaria nel passaggio al “dopo”: tra la fine del 1847 e l’inizio del 1848 era infatti avvenuta (cito) una «grande ed inaspettata rivoluzione», cui aveva dato fiato il giornale “Il Risorgimento”, venuto alla luce a Torino il 15 dicembre 1847 su impulso di Cesare Balbo e dello stesso conte di Cavour.
Organo del liberalismo moderato, “Il Risorgimento” aveva tenuto saldamente la linea del movimento riformatore, divenendo il capofila delle istanze per l’avvento del sistema rappresentativo. E ciò fintanto che Cavour, che ne era il direttore, con un colpo d’ala aveva spostato il gioco in questa sala, la Sala rossa del Palazzo di Città di Torino, affinché non dalla carta stampata, ma dal cuore delle istituzioni civiche della capitale giungesse al trono la solenne richiesta della Costituzione.
Quale il preludio dell’abilissima mossa?
Che le riforme del papa Pio IX e del granduca Leopoldo II di Toscana approvate nel 1846-47 avessero sollecitato aspirazioni più larghe in Piemonte, ove peraltro Carlo Alberto aveva da tempo varato importanti innovazioni in alcuni ambiti della pubblica amministrazione, è noto. Ed è noto che a Torino, ma ancor più a Genova, ove la lezione mazziniana aveva più alta incidenza, nell’ultimo scorcio del 1847 la tensione cresciuta a tutti i livelli avesse indotto il sovrano sabaudo a firmare vari e attesissimi nuovi provvedimenti di riforma: tra cui le limitazioni all’eccessivo potere della polizia, l’alleggerimento della censura, l’eleggibilità dei Consigli comunali. Provvedimenti peraltro tardivi, calati sul tappeto in un clima di montante ostilità contro l’Austria e in parte inattuati.
Tra la fine del 1847 e l’inizio del 1848, l’onda minacciosa degli eventi che agitavano l’Italia, dal Lombardo-Veneto al Regno delle Due Sicilie, lambì il Regno di Sardegna accentuando il contrasto tra i fautori del liberalismo e i suoi oppositori. A Genova, punta avanzata del movimento popolare, una deputazione di nove membri fu incaricata di deporre a Torino, nelle mani del Re, una petizione in cui si chiedeva sia l’istituzione della guardia civica armata, ritenuta necessaria onde resistere alle minacce esterne e interne al paese, sia l’espulsione dei padri della Compagnia di Gesù, notoriamente schierati con le forze reazionarie.
Giunti il 7 gennaio 1848 nella capitale, i delegati liguri furono invitati all’Albergo Europa per una manifestazione di solidarietà da parte di esponenti della stampa subalpina. In quella celebre riunione, il dibattito sulle misure limitate oggetto della richiesta genovese si allargò sfociando sorprendentemente nella proposta di impetrare (cito) «senza ambagi e francamente» una Costituzione. La mozione venne da Cavour. Osteggiata dai direttori della stampa di sinistra, fermi alla sola richiesta di una guardia civica, fu sostenuta dalla maggioranza dei presenti. Carlo Alberto rifiutò tuttavia l’incontro con i genovesi, sicché nessuna istanza giunse nelle sue mani.
Cavour non si diede per vinto: sostenuto dai direttori di alcuni giornali, Giacomo Durando dell’“Opinione”, Francesco Predari dell’“Antologia italiana”, Angelo Brofferio del “Messaggiere torinese”, organo quest’ultimo del radicalismo liberale, stilò una relazione circostanziata dell’accaduto, che fece pervenire al foglio fiorentino “La Patria”, ove fu integralmente pubblicata. La cosa irritò sommamente il sovrano. Tuttavia Cavour, imperterrito, tirò diritto, proseguendo la sua battaglia dalle pagine del “Risorgimento”.
Il colpo di grazia giunse con le notizie dell’insurrezione di Palermo, il 12 gennaio, e la sorprendente mossa di Ferdinando II di Borbone, che una quindicina di giorni dopo, il 29 gennaio, accordò ai Napoletani la Costituzione. Non c’era più tempo per le discussioni della stampa subalpina di vario orientamento sul quando e sul come. Cavour, risoluto, ruppe gli indugi e, testimone Michelangelo Castelli, affidò all’amico Pietro di Santa Rosa, compagno nella giovinezza di fruttuosi viaggi nell’Europa progressista, e da qualche tempo stimato decurione di Torino, il compito di farsi portavoce, nella sede istituzionale del Municipio torinese, della richiesta non di misure parziali, ma di una Costituzione secondo le attese del Paese.
Il 5 febbraio 1848 i sindaci convocarono in Sala rossa un «Consiglio generale straordinario» e invitarono Pietro di Santa Rosa a pronunciare il suo intervento. Levatosi dallo scranno, questi, evidenziando l’eccezionalità del momento («Noi, disse, viviamo in un’epoca tanto straordinaria»), invocò l’attenzione dei colleghi e presentò loro un riepilogo degli eventi ricordando le misure benevolmente elargite sino a quel momento dal Re; insistette inoltre sulla necessità di «rassodare gli ordini nuovi». In qual modo, se non con la Costituzione? «Ecco (cito) la gran parola […] che io stimo abbia a prendersi ad argomento della solenne proposizione che intendo sottoporre alla vostra attenzione».
La Costituzione, «il più essenziale […], massimo bisogno dell’epoca e dello Stato», secondo Santa Rosa (che, non dimentichiamolo, nell’aula prestava la sua voce a Camillo Cavour), avrebbe trovato un popolo maturo, educato e consapevole in ogni segmento della compagine sociale.
Con franchezza egli stigmatizzò: «Quando parlo di Costituzione, io, che appartengo al patriziato, protesto esser lungi da me il pensiero d’invocare […] privilegi nuovi […]; l’indole democratica de’ tempi, le condizioni dell’Italia, quelle del nostro paese vi si oppongono assolutamente». Invocò dunque: «Il Re, nella sua prudenza, proclami la Costituzione la più democratica che sarà possibile, io la applaudirò il primo». E aggiunse: «Quello che desidero è che si giunga a questo complemento con una concessione solenne, ma spontanea. Che il Re la conceda, coronandosi di nuova gloria, facendosi il benefattore più grande del suo popolo che vanti la storia; e non sorga il tempo in cui gli sia strappata dalla violenza per cui egli abbia a scadere dall’altezza a cui già s’innalzò».
Misurando le parole, fece infine appello ai colleghi decurioni: «Eccellenze, al cospetto di fatti e di commozioni così palpitanti, diam quest’esempio di coraggio civile, di suggerire al Re, nel caso supremo della patria, l’atto supremo da compiersi; e questa petizione, che noi daremo a questo scopo, sarà il fatto più solenne compìto in questa municipale magistratura dacché esiste; con esso finiremo gloriosamente, e, siatene certi, moriremo immortali».
All’applauso lungo e scrosciante che accolse i voti dell’oratore, seguì il silenzio assorto dell’aula. Poi ebbe inizio un pacato dibattito incentrato sul «modo d’inoltrare la domanda al regio trono»: sembrando opportuno lasciare «al magnanimo Monarca […] libera iniziativa» sulla larghezza delle concessioni. Santa Rosa, con altri tre colleghi, fu incaricato di predisporre il memoriale che i sindaci avrebbero deposto nelle mani di Sua Maestà. E il Consiglio rimase riunito «in seduta permanente».
Gli estensori del memoriale, evitando di menzionare la scottante parola ‘Costituzione’, blandirono il sovrano: «Il Corpo decurionale della fedelissima Città di Torino, scrissero, ha creduto che primo fondamento dovesse essere la conservazione di quell’armonia di sentimenti tra la Maestà Vostra ed i suoi sudditi, che fa la gloria del suo regno». Quella dell’assemblea decurionale, aggiunsero, non era un’indebita ingerenza, bensì un’iniziativa scaturita dal fondato timore che «la gravità sempre crescente degli avvenimenti succeduti in Italia potesse dare alle opinioni fatte libere una tendenza che per avventura venisse ad incagliare la libera azione governativa». «Corroborato» da «piena fiducia […] nella sapienza del Re», il decurionato aveva «preso a riflettere se non fosse il caso di supplicare [S.M.] di accelerare nell’ordinamento dei più alti poteri dello Stato lo sviluppo dei generosi pensieri» «ampiamente» espressi nel preambolo della legge 27 novembre 1847, che estendeva agli enti territoriali «il principio dell’uguaglianza civile già consacrato dai […] codici», stabilendo che l’amministrazione dei Comuni fosse affidata a Consigli elettivi.
Il 7 febbraio 1848 il conte di Cavour annunciò all’amico Émile De La Rüe, banchiere a Genova: «Qui a Torino un Consiglio straordinario discute la grande questione della Costituzione; io credo che sarà accordata senza ulteriori indugi». Quello stesso giorno Carlo Alberto ricevette con gelida cortesia i sindaci Vittorio Colli di Felizzano, marchese, e Giovanni Nigra, banchiere, esponente l’uno dell’aristocrazia cittadina, l’altro del ceto borghese. I due sindaci erano latori dell’indirizzo del Consiglio decurionale che con studiate perifrasi chiedeva la Costituzione. Il Re non rivelò la decisione presa il giorno stesso nel Consiglio di Conferenza, cioè di enunciare subito con proclama reale i principi fondamentali della carta, in attesa di una meditata formulazione della stessa. Limitò invece il suo dire a un laconico ed elusivo «Vedrò», condizionando tuttavia ogni decisione all’allontanamento immediato e silenzioso della folla assiepatasi sotto Palazzo Reale.
L’8 febbraio fu pubblicato il proclama costituzionale: i sindaci convocarono d’urgenza il Consiglio decurionale per rendere grazie al sovrano: Santa Rosa fu nuovamente chiamato a redigere, in segno di riconoscenza, un indirizzo da deporre ai piedi del trono. L’indirizzo, degno della gloriosa plurisecolare assemblea, plaudiva il «magnanimo atto» a coronamento di riforme «che avevano già reso splendido e glorioso il regno» e la dinastia. Il civico consesso, «non potendo moderare lo slancio della sua immensa gratitudine», sarebbe accorso al regale palazzo onde tributare al sovrano la propria riconoscente «ossequiosa espressione».
Carlo Alberto, accigliato e schivo, ricusò tuttavia qualsiasi omaggio: «Ringraziate da parte mia i vostri colleghi», disse severo al conte Nomis di Pollone, gentiluomo di Camera di S.M., che, essendo pur anche decurione, s’era fatto intermediario del corpo di appartenenza. «Ho deciso, aggiunse il Re, di non ricevere nessuna deputazione. […]. Ciò che ho fatto, l’ho fatto per la fortuna (le bonheur) del mio popolo […]. Non voglio né indirizzi, né ringraziamenti, né feste. Sarò felice, finanche troppo felice se i risultati corrisponderanno alle mie speranze. Ma per ottenere risultati è necessario che sia ristabilita la calma, che l’ordine pubblico non sia in alcun modo turbato». Infine, ed era la seconda volta, lamentò che i decurioni avessero sostituito l’antica coccarda azzurra sabauda con «une autre cocarde» (ossia il tricolore, ch’egli stesso di lì a poco avrebbe tuttavia inalberato passando in armi il Ticino per dare il via alla prima guerra di indipendenza).
Al decurionato, giunto definitivamente al tramonto della sua storia plurisecolare, non rimase che obbedire, consegnando agli archivi l’indirizzo stilato con tanta cura e rinunciando per il momento ai festeggiamenti di rito: non però al solenne Te Deum cantato nella chiesa propria della Città, ovvero al Corpus Domini, a pochi passi da Palazzo civico. La festa, «festa nazionale», ebbe luogo il 27 febbraio, sotto la regia accuratissima di Roberto d’Azeglio. Il re, pallido e assorto, assistette al grandioso evento a cavallo di un «baio bruno», «ritto e immobile, sì che pareva una statua». Nella postura regale, fu osservato, «si leggeva una maestà ineffabile, forse sorretta dalla coscienza d’aver eccitato la gioia e la gratitudine dei suoi popoli».
Finita la festa fu il momento del gran lavoro necessario alla formazione degli organi elettivi dello Stato. Il peso maggiore ricadde sul Comune, chiamato a stilare urgentemente le liste e a elaborare un progetto di ripartizione dell’area urbana e della periferia cittadina in circondari, ovvero in «collegi elettorali»: le elezioni politiche indette con decreto del 17 marzo, si sarebbero svolte il 27 aprile 1848, la prima guerra di indipendenza ormai in corso. La nuova legge sull’amministrazione dei comuni fu emanata il 7 ottobre; il 7 novembre i 2065 torinesi in possesso dei requisiti prescritti (non si trattava che dell’1,5% dei 136.849 abitanti) furono chiamati alle urne.
Nella graduatoria degli 80 consiglieri comunali che a Palazzo di Città avrebbero sostituito di diritto in Sala rossa i 60 decurioni decaduti, spiccavano i più bei nomi del Risorgimento italiano: alcuni erano transitati dal decurionato all’istituzione elettiva, come Giovanni Nigra, sindaco uscente, futuro ministro della Real Casa con Vittorio Emanuele II, primo della lista con 936 voti, o Pietro De Rossi di Santa Rosa, settimo con 849 voti; altri, ricchi di esperienza e di saperi maturati altrove, erano entrati per la prima volta nella compagine torinese. Tra costoro figuravano il senatore Roberto d’Azeglio, sesto con 879 voti; il teologo-filosofo Vincenzo Gioberti, decimo con 803 voti; Cesare Balbo, scrittore, Presidente del Consiglio del primo gabinetto costituzionale, sedicesimo con 699 voti; Cesare Alfieri di Sostegno, uno dei firmatari dello Statuto, presidente del Senato, diciottesimo con 688 voti.
Camillo Cavour, venticinquesimo con 622 voti, era l’unico a non vantare nel curriculum prequarantottesco incarichi pubblici di prestigio, non potendosi considerare tale il pur lungo sindacato, svolto senza passione dal 1832 alla vigilia del nuovo ordine, nel piccolo comune di Grinzane .
Fedeli allo Statuto (locuzione che Carlo Alberto aveva preferito alla voce ‘Costituzione’ di triste rimembranza), gli Alfieri, gli Azeglio, i Balbo, che per le libertà costituzionali s’erano spesi in luoghi e in modi diversi, avrebbero lavorato insieme per il paese, intrecciando finanche alleanze famigliari da cui di generazione in generazione sarebbe stata tramandata ai posteri la gloriosa memoria comune.
A Camillo Benso di Cavour, deputato dal 1848, ministro a capo di vari dicasteri dal 1850, chiamato quattro volte (dal 1852 al 1861) da Vittorio Emanuele II a costituire e presiedere un ministero, sarebbe toccato in sorte il grande disegno di modernizzare il Piemonte e di unificare l’Italia: senza abbandonare lo scranno di consigliere comunale di Torino, che serbò con orgoglio sino all’ultimo giorno di vita.
Rosanna Roccia
Palazzo di Città, Torino, 6 novembre 2023
175° del primo Consiglio comunale elettivo